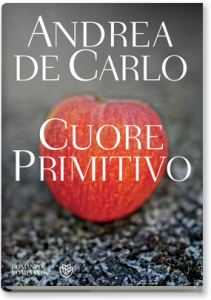 Non so per quale oscura ragione la sorella di mio marito, una dolce e affettuosa cognata, è convinta che io abbia, in una graduatoria di scrittori preferiti, posizionato ai primi posti Andrea De Carlo e Dacia Maraini. Ora, se per quest’ultima c’è un fondo di verità – apprezzo la scrittura al femminile della Maraini, ma non sempre è così per tutti i libri che ho letto – per De Carlo il discorso è diverso. Quando venne pubblicato Treno di panna, tanti anni fa, De Carlo era davvero una ventata di novità nell’asfittico panorama italiano, privo di giovani scrittori e di rivelazioni che costituissero la base di un rinnovamento letterario, in Italia, tanto da far scrivere ad Italo Calvino, sulla quarta di copertina del libro “L’insaziabilità degli occhi che vedono lo spettacolo del mondo multicolore ingigantito come attraverso la lente di ingrandimento. È questa la giovinezza che De Carlo racconta.” De Carlo costituiva la risposta italiana, se così si può dire, ai vari Bret Easton Ellis e Jay McInerney. Ha continuato poi a scrivere, a fotografare, a fare l’assistente regista, il musicista, il giudice in un talent show eccetera eccetera. Io ho continuato a ricevere in dono dalla cognata affettuosa i suoi libri, non tutti per fortuna, alcuni sì. Alcuni letti, altri no. L’ultimo in ordine temporale, e di pubblicazione e di regalo, è stato Cuore primitivo. La storia che De Carlo racconta propone l’eterno triangolo amoroso tra Essa, Isso e o Malamente – per dirla come in una sceneggiata napoletana. Nella fattispecie Essa è un’artista scultrice, un mix combinato di volitiva fragilità artistica, accoppiata ad un corpo non più giovane ma piacente e solido. Isso antropologo docente universitario, pedante quanto può esserlo uno che studia i comportamenti dell’intera razza umana, pesante nei giudizi, prevenuto nei rapporti con gli italiani, colui che pontifica a destra e a manca in programmi televisivi e sui social cosi, un raro esempio di inglese non innamorato dell’Italia. Il Malamente è un tatuato, operaio costruttore di tetti, privo di tatto e immaturo affettivamente. Tutti i personaggi sono descritti e vivono come da copione, come se dovessero obbligatoriamente rispettare uno stereotipo, l’artista estrosa e vitale, l’inglese noioso, l’operaio tombeur da strapazzo, senza mai scantonare, dalla prima all’ultima pagina. Un punto di vista che vorrebbe essere originale, con i tre che si fanno da controcanto ad ogni capitolo, ma poi finiscono per dispensare l’un l’altro sentimenti ambivalenti che vanno dal fastidio, all’intolleranza, al presunto compatimento, all’amore, qualche volta sì, qualche volta no, giù fino al finale, inatteso? Macché. Mi sono costretta a leggerlo, mi sarebbe sembrata una sgarbatezza verso la cognata affettuosa. Però o mi decido a svelarle il mio disinteresse verso De Carlo scrittore, oppure il prossimo romanzo lo cambierò a sua insaputa con un saggio sulle popolazioni primitive della Papuasia minore. Preferisco.
Non so per quale oscura ragione la sorella di mio marito, una dolce e affettuosa cognata, è convinta che io abbia, in una graduatoria di scrittori preferiti, posizionato ai primi posti Andrea De Carlo e Dacia Maraini. Ora, se per quest’ultima c’è un fondo di verità – apprezzo la scrittura al femminile della Maraini, ma non sempre è così per tutti i libri che ho letto – per De Carlo il discorso è diverso. Quando venne pubblicato Treno di panna, tanti anni fa, De Carlo era davvero una ventata di novità nell’asfittico panorama italiano, privo di giovani scrittori e di rivelazioni che costituissero la base di un rinnovamento letterario, in Italia, tanto da far scrivere ad Italo Calvino, sulla quarta di copertina del libro “L’insaziabilità degli occhi che vedono lo spettacolo del mondo multicolore ingigantito come attraverso la lente di ingrandimento. È questa la giovinezza che De Carlo racconta.” De Carlo costituiva la risposta italiana, se così si può dire, ai vari Bret Easton Ellis e Jay McInerney. Ha continuato poi a scrivere, a fotografare, a fare l’assistente regista, il musicista, il giudice in un talent show eccetera eccetera. Io ho continuato a ricevere in dono dalla cognata affettuosa i suoi libri, non tutti per fortuna, alcuni sì. Alcuni letti, altri no. L’ultimo in ordine temporale, e di pubblicazione e di regalo, è stato Cuore primitivo. La storia che De Carlo racconta propone l’eterno triangolo amoroso tra Essa, Isso e o Malamente – per dirla come in una sceneggiata napoletana. Nella fattispecie Essa è un’artista scultrice, un mix combinato di volitiva fragilità artistica, accoppiata ad un corpo non più giovane ma piacente e solido. Isso antropologo docente universitario, pedante quanto può esserlo uno che studia i comportamenti dell’intera razza umana, pesante nei giudizi, prevenuto nei rapporti con gli italiani, colui che pontifica a destra e a manca in programmi televisivi e sui social cosi, un raro esempio di inglese non innamorato dell’Italia. Il Malamente è un tatuato, operaio costruttore di tetti, privo di tatto e immaturo affettivamente. Tutti i personaggi sono descritti e vivono come da copione, come se dovessero obbligatoriamente rispettare uno stereotipo, l’artista estrosa e vitale, l’inglese noioso, l’operaio tombeur da strapazzo, senza mai scantonare, dalla prima all’ultima pagina. Un punto di vista che vorrebbe essere originale, con i tre che si fanno da controcanto ad ogni capitolo, ma poi finiscono per dispensare l’un l’altro sentimenti ambivalenti che vanno dal fastidio, all’intolleranza, al presunto compatimento, all’amore, qualche volta sì, qualche volta no, giù fino al finale, inatteso? Macché. Mi sono costretta a leggerlo, mi sarebbe sembrata una sgarbatezza verso la cognata affettuosa. Però o mi decido a svelarle il mio disinteresse verso De Carlo scrittore, oppure il prossimo romanzo lo cambierò a sua insaputa con un saggio sulle popolazioni primitive della Papuasia minore. Preferisco.
italo calvino
Ferito a morte
 Molte volte mi sono chiesta per quale ragione gli scrittori del Novecento italiano più capaci non sono riusciti ad avere quella risonanza, la fama, anche in patria, che meriterebbero. Non mi riferisco allo ” zoccolo duro ” della letteratura, Quasimodo, Montale e Ungaretti – la ” trimurti ” come li avevo battezzati ai tempi di scuola – che dopotutto, da poeti, sono riusciti a conquistare le antologie scolastiche e, forse, anche l’interesse dei lettori. Penso piuttosto a scrittori di prosa come Pratolini, Vitaliano Brancati, Raffaele La Capria, tanto per dire qualche nome – Calvino e Moravia mi sembra abbiano avuto vicende diverse e sono riusciti ad essere riconosciuti a livello più ampio e più ” popolare “. Il ” limite ” di un La Capria, ad esempio- se di limite si può parlare – è dato da una scrittura ” provinciale” che fa riferimento a fatti, cose e persone limitate a luoghi e situazioni ben definite. Ma provate a leggere Ferito a morte, il bellissimo romanzo, scritto e riscritto più volte da quel Dudù, che rimane il cantore più alto di un sentimento di napoletaneità, sentimento unico e ascrivibile ad una terra e ad un popolo e che allo stesso tempo sconfina in un sentimento più ampio, riconoscibile in ognuno di noi, quello che tocca la sfera delle emozioni e dell’introspezione. Il protagonista del libro, La Capria stesso, attraverso il flusso di coscienza – tecnica letteraria praticata da scrittori più noti universalmente, come Virginia Woolf – porta chi legge ad un coinvolgimento emotivo unico, le parole sono colore e pensiero, compongono un percorso mai lineare fatto di anfratti e nicchie, come sempre è il pensiero che vaga libero nella mente di chi è capace di pensare. Si fa fatica, all’inizio, a capire. La linea del tempo viene portata avanti e indietro continuamente – non si fa così quando si ricorda? – ma a partire da subito si viene abbacinati dai colori e dalla luce, dalle voci che Massimo De Luca ascolta in una giornata qualunque, dalla descrizione di una bella giornata. Al termine del libro viene voglia di rileggerlo subito perché il timore di aver perso qualcosa, di aver perso di vista coloro che hanno composto per una manciata di giorni – il tempo che ci vuole per leggere il romanzo, ma anche meno – un mondo fittizio e reale è un timore tangibile. Ci si distacca malvolentieri da Ferito a morte. Così poi viene da chiedersi come mai La Capria, a novantasei anni, sia conosciuto ai meno. Forse perché uno che ha scritto “La vita è ciò che ci accade mentre ci occupiamo d’altro ” non può ambire a molto credito, capaci di credere come crediamo che la vita è qui e adesso, fatta di banale concretezza, occupati come sempre a vivere altro, senza considerare quello che ci accade e senza volerne la consapevolezza.
Molte volte mi sono chiesta per quale ragione gli scrittori del Novecento italiano più capaci non sono riusciti ad avere quella risonanza, la fama, anche in patria, che meriterebbero. Non mi riferisco allo ” zoccolo duro ” della letteratura, Quasimodo, Montale e Ungaretti – la ” trimurti ” come li avevo battezzati ai tempi di scuola – che dopotutto, da poeti, sono riusciti a conquistare le antologie scolastiche e, forse, anche l’interesse dei lettori. Penso piuttosto a scrittori di prosa come Pratolini, Vitaliano Brancati, Raffaele La Capria, tanto per dire qualche nome – Calvino e Moravia mi sembra abbiano avuto vicende diverse e sono riusciti ad essere riconosciuti a livello più ampio e più ” popolare “. Il ” limite ” di un La Capria, ad esempio- se di limite si può parlare – è dato da una scrittura ” provinciale” che fa riferimento a fatti, cose e persone limitate a luoghi e situazioni ben definite. Ma provate a leggere Ferito a morte, il bellissimo romanzo, scritto e riscritto più volte da quel Dudù, che rimane il cantore più alto di un sentimento di napoletaneità, sentimento unico e ascrivibile ad una terra e ad un popolo e che allo stesso tempo sconfina in un sentimento più ampio, riconoscibile in ognuno di noi, quello che tocca la sfera delle emozioni e dell’introspezione. Il protagonista del libro, La Capria stesso, attraverso il flusso di coscienza – tecnica letteraria praticata da scrittori più noti universalmente, come Virginia Woolf – porta chi legge ad un coinvolgimento emotivo unico, le parole sono colore e pensiero, compongono un percorso mai lineare fatto di anfratti e nicchie, come sempre è il pensiero che vaga libero nella mente di chi è capace di pensare. Si fa fatica, all’inizio, a capire. La linea del tempo viene portata avanti e indietro continuamente – non si fa così quando si ricorda? – ma a partire da subito si viene abbacinati dai colori e dalla luce, dalle voci che Massimo De Luca ascolta in una giornata qualunque, dalla descrizione di una bella giornata. Al termine del libro viene voglia di rileggerlo subito perché il timore di aver perso qualcosa, di aver perso di vista coloro che hanno composto per una manciata di giorni – il tempo che ci vuole per leggere il romanzo, ma anche meno – un mondo fittizio e reale è un timore tangibile. Ci si distacca malvolentieri da Ferito a morte. Così poi viene da chiedersi come mai La Capria, a novantasei anni, sia conosciuto ai meno. Forse perché uno che ha scritto “La vita è ciò che ci accade mentre ci occupiamo d’altro ” non può ambire a molto credito, capaci di credere come crediamo che la vita è qui e adesso, fatta di banale concretezza, occupati come sempre a vivere altro, senza considerare quello che ci accade e senza volerne la consapevolezza.